Il primo respiro
non è solo aria.
È una frattura.
Il torace si apre,
i polmoni bruciano,
il mondo entra senza chiedere permesso.
E in quel pianto iniziale
c’è già tutto:
paura, stupore,
voglia di restare.
Respirare è accettare.
Accettare di essere vivi.
Poi impariamo a farlo senza pensarci,
come se fosse scontato.
E invece no.
Non lo è mai.
C’è il respiro dell’amore —
lento, profondo,
che si sincronizza con un altro petto
fino a non capire più
chi inspira e chi trattiene.
C’è il respiro della rabbia —
corto, duro,
come un pugno che preme contro lo sterno.
È il fuoco che ci attraversa
prima che impariamo a perdonare.
C’è il respiro della fatica,
quando il turno è lungo,
le gambe pesano,
e l’aria sembra poca.
Ma continui.
Perché qualcuno, davanti a te,
ha bisogno del tuo fiato calmo
per non perdere il proprio.
C’è il respiro dopo una maratona,
quando il cuore esplode nel petto
e l’aria entra a ondate,
violenta e gloriosa.
In quell’ansimare c’è la prova
che siamo limite
e superamento del limite.
Che il dolore può trasformarsi
in luce chimica nel sangue.
C’è il respiro della risata,
quello che si spezza
tra le lacrime e l’abbraccio.
È il più puro.
Perché dimentica la morte
anche solo per un istante.
E poi c’è il respiro fragile.
Quello che rallenta.
Quello che si assottiglia come un filo.
L’ho visto —
lo abbiamo visto —
diventare silenzio.
Non fa rumore la fine.
È un soffio che si arrende
con una dignità che commuove.
L’ultimo respiro
non è sconfitta.
È restituzione.
Restituiamo l’aria al mondo
come si restituisce un dono ricevuto in prestito.
E allora capisci
che tutta la vita
è stata solo questo:
una sequenza di attimi
tra un’inspirazione e un’esalazione.
Respirare è fidarsi.
È lasciare entrare.
È lasciare andare.
E finché il petto si solleva,
finché l’aria attraversa la carne,
abbiamo un compito semplice e immenso:
trasformare ossigeno
in amore.
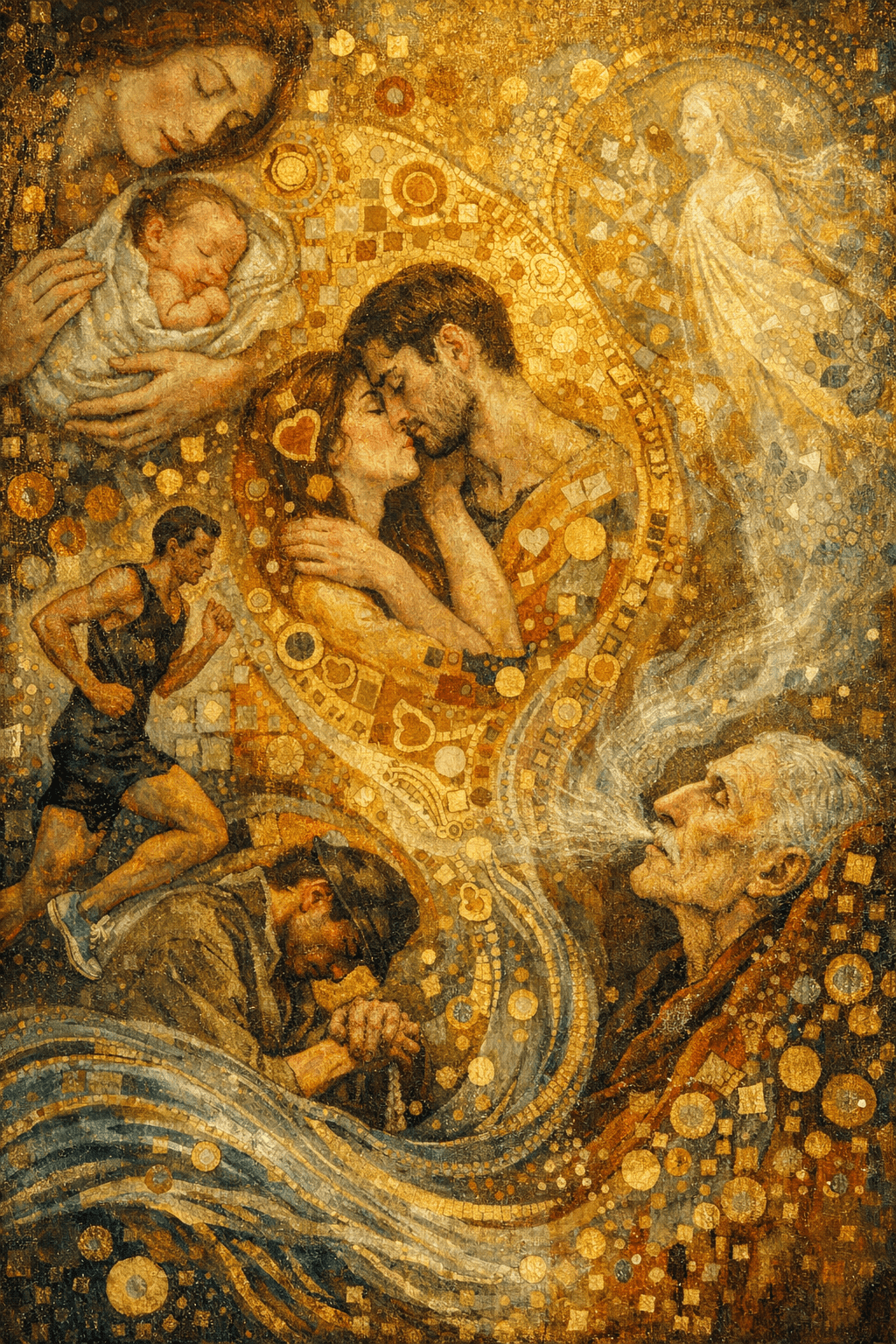
Lascia un commento